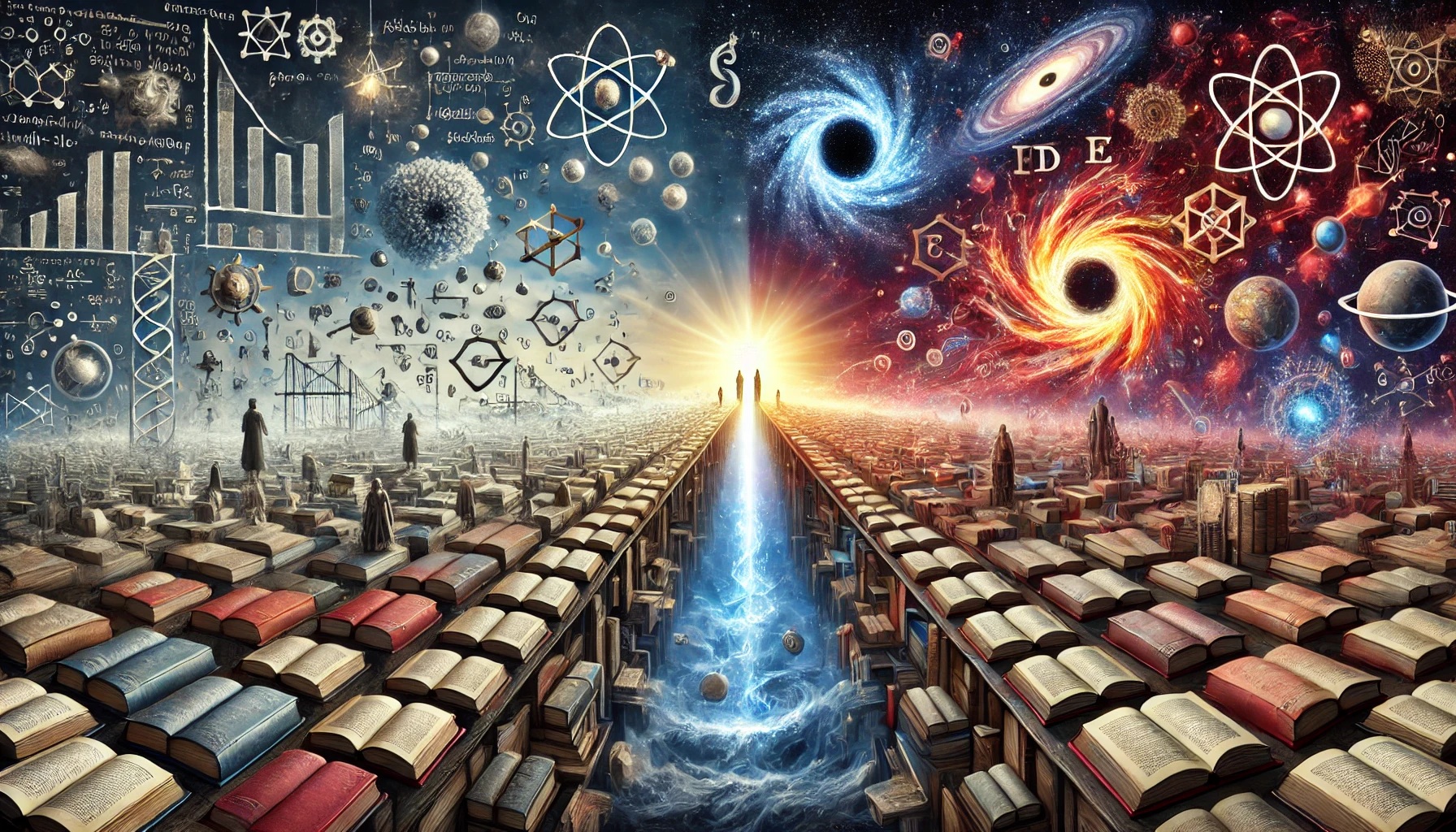
di Marcello Colozzo
Per Thomas Khun la conoscenza scientifica si realizza attraverso “mutamenti di paradigma”. In tali transizioni, un ruolo fondamentale è svolto dalla comunicazione verbale e quindi, dalla propaganda. Con le parole di Khun: «la verità è nel potere».
In un numero precedente abbiamo introdotto il falsificazionismo di K. R. Popper, una corrente filosofica che stabilisce un criterio di demarcazione tra scienza e non scienza.
Nei decenni successivi, le tesi popperiane furono oggetto di ampio dibattito, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, in occasione della pubblicazione del saggio The Structure of Scientific Revolutions[1] dell’epistemologo Thomas S. Kuhn (Cincinnati 1922 – Cambridge 1996).
Secondo Khun la conoscenza scientifica si realizza attraverso due modalità complementari: 1) modalità normale; 2) modalità rivoluzionaria. Nella prima ritroviamo una “comunità scientifica” che stabilisce l’esistenza di principi e regole generali. Ed è solo la fede in tali principi ad essere il fondamento della cosiddetta “prassi ulteriore”. Scrive Khun: «Il paradigma è costituito da conquiste scientifiche universalmente riconosciute, le quali, per un certo periodo di tempo, forniscono un modello di problemi e soluzioni accettabili a coloro che praticano un certo campo di ricerca».
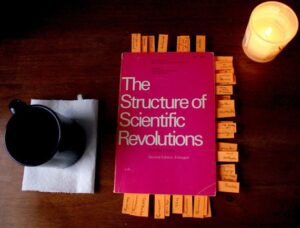
Ad esempio, un paradigma può essere costituito da una teoria T il cui requisito fondamentale è il seguente: T deve risultare migliore di altre teorie T’, T”, … in competizione con T.
È evidente che la modalità normale esibisce la massima performance nelle scienze applicate, per cui essa assume i connotati di una modalità di tipo ingegneristico.
Inoltre, eventuali soluzioni “inattese” sono escluse dall’indagine scientifica in modalità normale.
Quando, invece, si presentano delle “anomalie” cioè fatti sperimentali inspiegabili nella modalità normale, la fede nel paradigma viene indebolita. Lo step successivo consiste in una proliferazione di teorie contrastanti che compongono secondo Khun, il “nucleo della crisi” che implode in corrispondenza di anomalie “irriducibili” ovvero non risolvibili nella modalità normale. L’aumento progressivo del numero di studiosi consapevoli dell’esistenza di anomalie irriducibili, determina la transizione dalla modalità normale alla modalità rivoluzionaria, in cui l’evento risolutore è rappresentato dalla nascita di un nuovo paradigma.

La realizzazione di un nuovo paradigma è un evento discontinuo, cioè “istantaneo”. Scrive Khun: «[il paradigma] emerge tutt’a un tratto, talvolta nel buio più completo, nella mente di uno scienziato profondamente immerso nella crisi».
La “rivoluzione scientifica” è, dunque, costituita dalla transizione da un paradigma a un altro, transizione che si realizza grazie a “lampi di intuizione” interpretabili attraverso eventi psichici, irriducibili e allocati nel subconscio di quella speciale classe di studiosi profondamente immersi nella crisi. A nostro avviso, un esempio emblematico è offerto da Werner Heisenberg, uno dei principali artefici della “rivoluzione quantistica”. Scrive Heisenberg[2]: «Ricordo le discussioni con Bohr che si prolungavano per molte ore fino a tarda notte e che ci conducevano quasi a uno stato di disperazione; e quando al termine della discussione me ne andavo da solo a fare una passeggiata nel parco vicino, non potevo fare a meno di ripropormi in continuazione il problema: è possibile che la natura sia così assurda come ci appare in questi esperimenti atomici?».
Secondo Khun, i “lampi di intuizione” che innescano la transizione al nuovo paradigma, non hanno alcun legame logico e fattuale col vecchio paradigma. Ad esempio, il “quanto d’azione” introdotto nel 1900 da Max Planck, per risolvere l’enigma dell’emissione del corpo nero, è completamente estraneo alla fisica classica. Infatti, Planck inizialmente interpretò tale oggetto alla stregua di un artificio matematico finalizzato alla risoluzione del problema, per poi concludere che il quanto d’azione ovvero la quantizzazione dell’energia, caratterizzava il processo fisico in esame. Incidentalmente, il quanto d’azione si presentò nella seconda metà dell’Ottocento in una argomentazione di Hamilton, secondo la quale il moto di una particella (nel paradigma della meccanica classica) equivale alla propagazione di un’onda che obbedisce a un’equazione differenziale del tipo Schrödinger, in cui compare una costante fisica con le dimensioni di una “azione” (cioè, energia x tempo), e che si identifica con la grandezza trovata successivamente da Planck. Per questa ragione, il risultato di Hamilton venne interpretato come la conseguenza di un formalismo matematico privo di significato fisico.
Siamo, quindi, ben lontani dalla continuità temporale prevista dal falsificazionismo di Popper. L’inevitabile incommensurabilità tra un paradigma e il successivo, determina una “carica irrazionalistica” che è il building block dell’approccio psico-sociologico di Khun. Egli scrive: «la competizione tra paradigmi diversi non è una battaglia il cui esito possa essere deciso sulla base delle dimostrazioni».
Secondo Khun, l’adesione a un determinato paradigma è determinata da ragioni di natura propagandistica, che spesso assumono l’aspetto di un atto di fede. In ciò ravvisiamo un legame con lo scientismo, corrente filosofica ampiamente criticata dallo stesso Popper, attraverso il noto aforisma: «Se lo scientismo è qualcosa, esso è la fede cieca e dogmatica nella scienza. Ma questa fede cieca nella scienza è estranea allo scienziato autentico».
[1] Khun T. S., La Struttura delle Rivoluzioni Scientifiche, Einaudi 2009.
[2] Heisenberg W., Fisica e Filosofia. Il Saggiatore 1963.
[3] Belloni E., Thomas S. Khun: “Paradigmi” e “Rompicapi” nella Ricerca Scientifica, Annuario della EST 1976.
[4] Lunghi S., Karl Popper: Verifica e Falsificazione delle Teorie, Annuario della EST 1976.